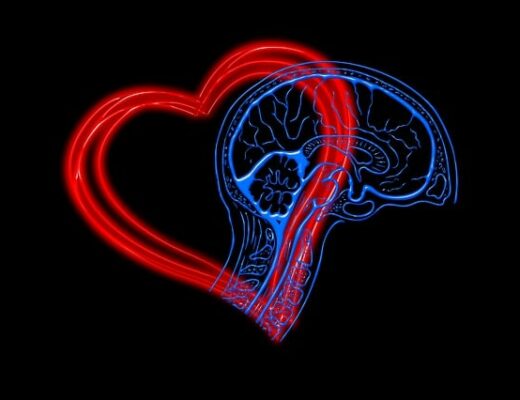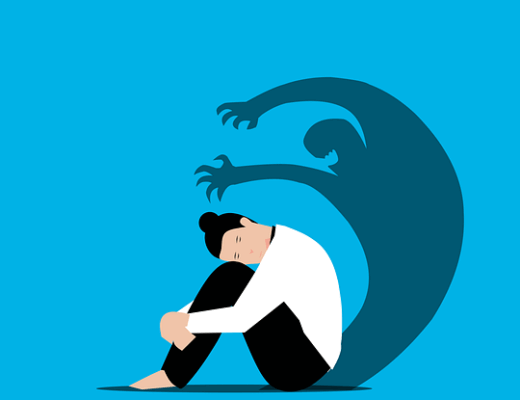Le prime riflessioni sul Sé e sulla valutazione di sé.
A quando risale la prima definizione di autostima? Difficile dirlo, tra vari autori che negli anni ne hanno parlato. Nel tempo si sono generate diverse definizioni. È stato indicato comunque che l’autostima fa parte di una dimensione più grande, data dalle immagini e riflessioni su se stesse che le persone creano, o i loro Sé.
Pare che si debbano allo psicologo americano William James le prime definizioni legate al Sé e alla sua valutazione, o autostima. In The Principles of Psychology (I principi della psicologia, 1890), infatti, lo psicologo americano parlava della coscienza di sé. Sviluppava discorsi su esperienze del sé, sentimenti del sé, ricerca di sé e autoconservazione, amore per il sé (Self-love).
Per James l’esperienza del sé è divisa in ricerca del sé e valutazione del sé (Self-Estimation).
Interessanti sono i contenuti della ricerca del sé, nella dimensione sociale: desiderio di piacere, di essere notati e ammirati, socievolezza, emulazione, invidia, amore, ricerca dell’onore, ambizione. Nella dimensione spirituale della ricerca del sé indicava invece: aspirazione intellettuale, morale e religiosa, coscienziosità.
Nella valutazione del sé invece, indicava per la dimensione sociale: orgoglio sociale e familiare, vanagloria, snobismo, umiltà, vergogna. E nella dimensione spirituale: senso di superiorità morale o mentale, purezza, senso di inferiorità o di colpa.
Le riflessioni di Natalien Branden.
Lo psicologo americano Natalien Branden incentrò il lavoro di psicoterapeuta intorno a questo concetto (I 6 Pilastri dell’autostima, 2005). Ragionevolmente cercò di darne una definizione utile e pratica. Per Branden l’autostima pienamente realizzata è sentire di essere adeguati alla vita e alle sue richieste, con:
1.la fiducia nelle nostre capacità di pensare e di superare le sfide fondamentali della vita
2.la fiducia nel nostro diritto al successo e alla felicità, nel nostro diritto di affermare le nostre necessità e desideri, di realizzare i nostri valori e goderci i frutti dei nostri sforzi; la sensazione di valere e di meritare tutto questo. La prima affermazione somiglia molto al concetto di autoefficacia di Albert Bandura.
La felicità può essere un concetto fuorviante.
Per la seconda affermazione vista sopra di Branden, si fa un appunto solo riguardo al termine felicità, che rappresenta un concetto difficilmente definibile. Inoltre, come hanno rilevato alcuni psicoterapeuti come Paul Watzlawick (Istruzioni per rendersi infelici, 1983) e Russ Harris (La trappola della felicità, 2010), può comportare dei rischi riguardo alle aspettative che si porta dietro. Per il primo, abbiamo creduto a lungo ingenuamente come esseri umani che la ricerca della felicità porti alla felicità. Per il secondo, la trappola della felicità è una lotta infruttuosa contro i pensieri e le emozioni negative, persa in partenza perché è una lotta contro la realtà e la natura dell’essere umano. Così, la ricerca incessante della felicità porta paradossalmente a maggiore infelicità e sofferenza.
Nonostante le definizioni dei vari autori, inevitabilmente i parlanti contaminano di significati e sfumature sempre nuovi i termini di uso quotidiano. Se l’etimologia del termine stimare possiede i due significati di valutare e avere un’opinione, ognuno avrà in mente un significato della parola autostima personalissimo. Semplicissima è la definizione del 1965 del sociologo Morris Rosenberg: l’autostima sarebbe la valutazione che la persona ha sui vari aspetti di sé.
Più di 200 definizioni diverse, e 3 elementi comuni.
Per la professoressa di Psicologia dell’Università di Chieti-Pescara Elisabetta Bascelli (Il bambino in classe, 2008), nonostante il concetto si porti una storia di elaborazioni e 200 definizioni diverse, 3 elementi fondamentali le distinguono:
- un sistema di autosservazione o di autoconoscenza che usa termini descrittivi per definire le proprie caratteristiche;
- un aspetto valutativo che permette un giudizio generale di se stessi;
- un aspetto affettivo che permette di valutare in modo positivo o negativo gli elementi descrittivi
Inoltre, l’autostima sarebbe una componente dell’immagine di sé, appunto formata da 4 dimensioni psicologiche:
- motivazione
- autoefficacia
- autostima
- stile di attribuzione.
Il concetto di sé è quindi l’insieme degli elementi cui una persona fa riferimento per descrivere se stessa. L’autostima è una componente specifica della rappresentazione di sé che coincide con una valutazione delle informazioni contenute nel concetto di sé.
Alcune componenti dell’autostima.
La professoressa di Psicologia della personalità dell’Università di Padova Angelica Moè, nel suo libro sull’argomento (Autostima, 2014), indica che la definizione di Rosenberg dell’autostima come “valutazione globale di sé” sia quella più comunemente accettata. La Moè ci parla di due sfumature del valutare se stessi, una che riguarda il piacersi, e l’altra che ha a che fare con il sentirsi competenti. Indica inoltre che le autovalutazioni personali (self-evaluations) sono di vario tipo, non corrispondono all’autostima ma ne sono legate e ne sono conseguenza:
- Self-efficacy (autoefficacia – il sentirsi capaci nel fare una cosa, la fiducia nel riuscire)
- Self-determination (autodeterminazione, scelta di chi si vuole diventare e le ragioni)
- Self-control (autocontrollo)
- Self-regulation (autoregolazione – capacità di coordinare, modulare, modificare strategie funzionali ad obiettivi da sé definiti e in cui si crede)
- Self-concept (insieme di definizioni di sé in vari ambiti non valutative)
Alcune critiche ad un concetto omnicomprensivo.
Ci sono altri autori, come Antonio Iudici e Manola Fava, che mettono in guardia giustamente dal rischio che il concetto di autostima diventi un contenitore di troppe dimensioni psicologiche e perda il suo valore di spiegazione e di utilità pratica. Un esempio che viene in mente è che ogni problema psicologico può essere percepito come un problema di autostima. Un ulteriore rischio è anche quello che si creino dei nessi di causa-effetto complessi e difficili da dimostrare, del tipo “ho questo problema perché ho una bassa autostima”, oppure “ho una bassa autostima, quindi non posso fare questo lavoro”, che diventano delle credenze limitanti per le persone o delle “profezie che si autoavverano”.
Un concetto dalle molteplici definizioni soggettive.
Nel corso degli anni, durante i corsi di formazione e in studio durante consulenze e terapie, ho letto e ascoltato centinaia di definizioni dai vari interlocutori. Queste sono molto più interessanti di quelle degli addetti ai lavori, perché sono personalissime e si portano dietro il punto di vista, l’esperienza e le emozioni, gli obiettivi e i risultati individuali delle persone. E la bellezza della vita di ognuno, anche nelle difficoltà e nelle sfide. Inoltre, ci danno il messaggio che non ci deve essere un modo giusto o vero in assoluto di intendere un concetto, ma il suo significato è relativo al modo personale di sentire, percepire e narrare le cose dell’interlocutore.
Eccone di seguito alcune:
– Non porsi limiti alla propria realizzazione
– Saper convivere con vecchie paure o vincerle
– Non farsi abbattere dagli eventi
– Pensare positivamente
– Essere più determinati e osare di più
– Non dipendere dagli altri e non sentire che tutto ciò che faccio è sbagliato
– Essere più fermi sulle proprie decisioni, meno indecisi
– Eliminare la paura di non riuscire e il blocco ad agire
– Credere nelle nostre scelte senza il bisogno del consenso degli altri
– Non avere sensi di colpa verso gli altri
– Andare a testa alta anche se non si viene compresi
– Non temere il giudizio degli altri
– Uno scudo per difendersi da personalità più forti
– Essere più tranquilli nel rapporto con gli altri e piacersi
– Saper collaborare meglio coi colleghi e saper trasmettere l’idea di competenza
Ogni definizione può indicare un problema e un’opportunità
Ognuna di queste definizioni porta con sé criticità in vari aspetti della vita, che possono però essere trasformate in interessanti sfide e opportunità. Dietro le varie paure indicate, c’è il quotidiano coraggio dell’essere umano nell’affrontarle, e la soddisfazione nel superarle. Dietro a diverse di queste definizioni ci sono le sfumature di un continuo confronto con gli altri nel contesto sociale. Ad esempio, nel timore del giudizio altrui, nel cercare un confronto costruttivo nei rapporti, nel non sentirsi sminuiti da personalità che ci pare brillino più di noi. Pare, perché alcune volte gli altri sembrano solo, ma non sono, “più” di noi. In proposito lo scrittore Ernest Hemingway disse “non c’è nulla di nobile nell’essere superiore agli altri. La vera nobiltà consiste nell’essere superiori a chi eravamo ieri”. E quando abbiamo obiettivi di apprendimento continuo e curiosità verso le cose e la vita, c’è sempre l’opportunità di non perdersi qualcosa da imparare ogni giorno, superando le conoscenze di ieri.
Il confronto con gli altri.
George Herbert Mead (filosofo, sociologo, psicologo statunitense), considerato uno dei padri fondatori della psicologia sociale, sottolineava l’importanza dell’interazione sociale per la costruzione dell’idea che abbiamo di noi stessi (e non dell’introspezione), con la capacità di assumere il punto di vista dell’altro e di confrontarsi con prospettive diverse.
Nel quotidiano confronto con gli altri, e con noi stessi, la valutazione che diamo di noi può essere considerata anche un viaggio di scoperta attraverso un percorso di crescita personale, in cui trasformiamo le sfide in opportunità. A volte il confronto con gli altri ha come risultato delle valutazioni inique. Vediamo spesso gli altri come migliori e più fortunati e noi come di minor valore, ma spesso sono lenti deformate quelle con cui guardiamo a noi stessi. Sono lenti svalutanti. E nel confronto con gli altri più “bravi” in qualcosa veniamo spesso inibiti in quell’attività. Spesso ci può aiutare il guardare meno alle prestazioni altrui, a meno che non riusciamo a trovarne ispirazione, e il focalizzarci di più sul superare noi stessi ogni giorno.
Il viaggio di scoperta quotidiano.
Riprendendo qualcuna delle definizioni sopra, ad esempio “eliminare la paura di non riuscire e il blocco ad agire”, la criticità potrebbe essere trasformata in un progetto di cambiamento, da soli o affiancati con un professionista, in cui si affronta la paura di sbagliare, capendo in che contesti avviene, e si progetta la ripresa dell’azione, anche per piccoli passi. Nella definizione “non porsi limiti alla propria realizzazione” c’è dietro la possibilità di rivedere i contesti e gli ostacoli di questa realizzazione personale e l’individuazione degli obiettivi in linea con tale realizzazione, nonché l’individuazione delle difficoltà sopraggiunte e i modi e le strategie per superarle.
Come diceva lo scrittore Marcel Proust in una frase citata molto spesso, ma sempre pertinente con il cambiamento “il vero viaggio di scoperta non consiste nel vedere nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. A volte possiamo meravigliare noi stessi uscendo dagli schemi consolidati e da vecchie convinzioni, valutando i problemi attraverso diverse cornici di lettura. Altre volte è possibile scoprire nuovi mondi valutando diverse modalità d’azione, e, attraverso queste, proiettarci in nuovi modi di percepire le cose che ci portano verso cambiamenti più funzionali per noi.
Giovanni Iacoviello
Sta per partire il Laboratorio di Autostima per il lavoro e nella vita, che si terrà per 3 sabati mattina dal 31 gennaio. Riduzioni della quota per chi la versa entro il 19 gennaio. Scopri di più.
Per non perderti contenuti e notizie sui prossimi corsi ed eventi, iscriviti alla Newsletter.
Per fissare un colloquio o una consulenza, compila il modulo di contatto qui sotto.